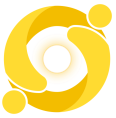Secondo una stima dell’autorevole settimanale “The Economist”, nel 1981 in Sudafrica c’erano «duecento consiglieri militari di Tel Aviv». Questi prestavano la loro opera «soprattutto nei reparti speciali sudafricani, come quello dei Reconaissance Commandos», che dovevano molto ai propri istruttori israeliani. A questo proposito, il quotidiano del Partito laburista israeliano “Sa Labour News” scrisse:
«È un segreto di Pulcinella che nei campi militari (sudafricani, nda) vi sia un numero non indifferente di ufficiali israeliani che addestrano militari bianchi a combattere i terroristi neri secondo i metodi adottati in Israele».
I giovani bianchi sudafricani potevano scegliere se combattere diciotto mesi in Angola o se fare i poliziotti in una township per due anni. Il servizio civile, inutile dirlo, non esisteva. La maggior parte dei ragazzi, condizionati da una scuola militarizzata, accettavano di buon grado le durezze della guerra (interna ed esterna), ma anche chi non era d’accordo era costretto a partire per il fronte.
Quando incontrai John Davenport aveva trentun anni. La sua era sempre stata una famiglia democratica. Fu chiamato alle armi nel 1987. Aveva studiato medicina ed era un pacifista convinto. Egli aveva chiesto l’esenzione dal servizio militare ma gli era stata negata. Allora, aveva fatto richiesta di poter prestare servizio in qualche ospedale miliare lontano dal fronte. Questa volta era stato accontentato.
Due mesi dopo, un ordine superiore lo aveva fatto trasferire in uno dei tanti campi nel nord della Namibia, quelli che venivano usati come base di partenza per i raid in territorio angolano.
«Un ufficiale mi accolse dicendomi: “Questo è il fucile in tua dotazione, domani farai la tua prima missione”», mi raccontò John.
«La guerra aveva trasformato i miei compagni in bestie. Anzi, mi correggo, gli ufficiali istruttori israeliani avevano trasformato i miei compagni in bestie. Poi era venuta la guerra che, con i suoi orrori, aveva completato il lavoro. Partii con loro e quello che vidi non lo scorderò mai più: sangue, sangue e ancora sangue. Ne vidi così tanto che adesso non ne posso più fare a meno».
E gli israeliani che ruolo avevano?
«Loro ci incitavano a fare sempre di più. Uno di loro un giorno mi disse: “Devi capire che le bestie che combattiamo qui in Angola sono le stesse che troviamo in Israele. Noi abbiamo bisogno di quelle che a voi sembrano crudeltà, perché dobbiamo comprendere fino a cosa possiamo fare in Israele e in che modo farlo per rendere le nostre azioni militari più efficaci”».
Per loro i massacri erano esperimenti sociali? «A quanto pare sì».
Ha ucciso molte persone in guerra? «Sì, tante».
E dopo la guerra, da quando è tornato a casa?
«Ho continuato a uccidere. Giro sempre con la pistola e in ogni momento di pericolo, anche il più banale, la tiro fuori e talvolta sparo. Oramai ammazzare qualcuno non mi fa più effetto».
Mi racconta un episodio di allora?
«Entriamo in un villaggio angolano. Uccidiamo tutti, anche i neonati. Saranno stati più di cinquanta. Poi leghiamo alcuni di loro al nostro blindato e torniamo indietro, verso il campo. Per il lungo viaggio e il caldo i corpi cominciano a puzzare. Quando arriviamo al campo il comandante ci dice: “Siete matti? Riportate immediatamente questi corpi al villaggio e seppelliteli”. Io allora sono sceso dal carro e ho puntato la pistola in faccia all’ufficiale. “Che cosa ha detto, signore?”».
Ci furono problemi in seguito? «No, il capo aveva paura di noi».
Tratto dal libro Guerra alla Pace, di Franco Fracassi.
Per acquistare il libro, scrivi all’indirizzo email: francofracassi1@gmail.com