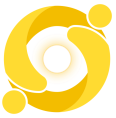«Lei è proprio sicuro di non sapere perché si trova in stato di fermo?».
Ero appena sbarcato all’aeroporto di Kiev, tappa intermedia per Odessa, la mia destinazione finale. Il mio percorso in territorio ucraino era stato di appena cento metri: dal portellone dell’aereo fino al controllo passaporti, passando per un corridoio tutto vetri e tapis roulant.
La mia mente era intenta a ripercorrere il minuto e mezzo di percorso e i successivi dieci in attesa di passare la frontiera. Ne ero proprio certo. In quel frangente non avevo commesso alcun reato.
«Senta, può verificare che il mio passaporto è autentico, che nella mia valigia non ci sono armi né altri oggetti illegali, che non c’è stato alcun contatto tra me e qualsivoglia passeggero. No, non lo so perché mi trovo in questa stanza piena di poliziotti e di agenti segreti».
La donna dietro la scrivania era seriamente convinta che la stessi prendendo in giro. Un noto criminale come me, appartenente alla pericolosissima razza dei giornalisti, sarebbe stato in grado di traviare chiunque. Nei suoi occhi si leggeva tutto questo.
«Va bene. Firmi questo foglio e vada via».
«Firmerò solo dopo che mi avrete tradotto che cosa c’è scritto».
«Io, responsabile del servizio di controllo della frontiera, la dichiaro in stato di fermo perché lei ha cercato inopinatamente di entrare in Ucraina. Lei, Franco Fracassi, giornalista, cittadino italiano eccetera dichiara di essere a conoscenza di essere “nemico del popolo ucraino”, e in quanto tale non benvenuto in Ucraina».
L’invito in Ucraina
Ero stato invitato a Odessa per le celebrazioni del primo anniversario della strage. Grazie ai miei tanti articoli d’inchiesta scritti sulla strage, ero stato il giornalista internazionale prescelto per essere testimone di quella ricorrenza.
Invece (erano le 18.16 del primo maggio 2015) ero stato formalmente accusato di uno strano reato ideologico e mi apprestavo a passare una notte in cella.
La simil prigione in cui mi avevano rinchiuso al posto dei muri aveva vetrate. Mi sentivo un pesce in un acquario, insieme ad altri pesci che avevano le sembianze di una prostituta nigeriana, di due trafficanti daghestani, di tre immigrati illegali tagiki, di uno spacciatore turco.
Fuori dell’acquario dieci soldati armati di mitra. Era una strana cella, dove ciascuno poteva tenere con sé i propri bagagli, cellulare compreso.
Due chiamate: la prima a mia moglie Giorgia, la seconda alla persona che aveva organizzato il mio viaggio. «Mi hanno arrestato. Aiutatemi».
Avevo dato inizio a una vera e propria danza fatta di telefonate internazionali, di colloqui con l’ambasciata italiana a Kiev, di tentativi di dialogo con i soldati che mi tenevano in custodia.
La cosa più paradossale era proprio quest’ultima, perché tutte, ma proprio tutte le persone (ucraine) con cui ho avuto a che fare parlavano solo in russo, mai in ucraino. Nonostante si trattasse di nazionalisti ucraini che avevano bandito la lingua russa come lingua ufficiale.
«Il console è imbufalito»
Un’ora. Due ore. Tre ore. «Buona sera, sono l’addetto politico dell’ambasciata. Mi trovo all’aeroporto insieme al console. C’è un problema. Le autorità non ci fanno passare. Ci vietano di incontrarla, in barba a qualsiasi diritto internazionale. Il console è imbufalito».
Tre ore e mezza. «Buona sera. Non ci siamo dimenticati di lei. Ma qui stanno veramente facendo ostruzionismo».
Quattro ore. «Ancora nulla. Tenga duro».
Nel frattempo, avevo anche vissuto l’esperienza surreale della toilette sorvegliato a vista da un soldato armato di mitra mentre espletavo i miei bisogni, alla stregua di un qualunque noto criminale pronto a evadere.
Quattro ore e mezza. Dopo avermi toccato la spalla, uno dei soldati mi fece cenno di seguirlo, «con tutta la mia roba».
Erano quasi le undici e l’aeroporto era chiuso. Non c’era più nessuno. Più nessun volo in attesa. Gran parte dei corridoi bui. L’unico luogo animato era l’acquario-prigione con le sue vicinanze.
Il soldato mi fece cenno di avvicinarmi a uno dei gabbiotti per il controllo passaporti e mi chiese il foglio di via, consegnandomi in cambio il passaporto sequestrato. Non una parola, non un cenno di scuse, non un’indicazione.
Improvvisamente ero di nuovo un cittadino libero ed ero libero di entrare in Ucraina. Davanti a me un dedalo di corridoi, tutti rigorosamente bui. Per la prima volta nel corso di quella serata ebbi paura.
La strada verso il portellone degli arrivi dell’aeroporto sembrava infinita. Lunghi corridoi immersi nell’oscurità, scale mobili non funzionanti, sale deserte. Non c’era più nemmeno l’addetto al controllo bagagli dell’immigrazione.
La paura
Temevo che potesse sbucare qualcuno con un coltello e farmi fuori. Nessuno mi avrebbe difeso, nessuno avrebbe potuto testimoniare. Era un timore che scoprii non essere campato in aria. Fuori non c’era nessuno ad attendermi. Il funzionario dell’ambasciata e il console sarebbero arrivati dopo un po’, perché trattenuti dalle autorità ucraine.
Nell’ora seguente compresi le seguenti cose: ero stato rilasciato grazie all’encomiabile lavoro svolto dall’ambasciatore e dal suo staff, l’ordine di rilascio era giunto direttamente dal ministro dell’Interno ucraino, ero stato sospettato di aver addirittura combattuto nel Donbass, il mio nome era stato inserito in una lista nera.
Avete presente l’America Latina degli squadroni della morte? Ecco l’Ucraina del 2015. Chi dissentiva, chi contestava, chi provava a raccontare la verità su ciò che stava accadendo era nemico del popolo ucraino, e in quanto tale da eliminare.
Venni a sapere che la lista nera era stata stilata dagli squadroni della morte nazisti che avevano imperversato nell’ultimo anno nel Paese. Venni a sapere che nella lista figuravano anche i nomi di mia moglie e di mio figlio di tre anni e mezzo.
Venni a sapere che la lista era stata consegnata al ministro dell’Interno Arsen Avakov, anche lui seguace dichiarato di Hitler. Venni a sapere che la lista era stata presa in carico dal ministero dell’Interno, ragione per la quale ero stato fermato al mio arrivo.
Venni a sapere che nella sola settimana precedente erano stati assassinati quattro giornalisti (anche non ucraini), nel silenzio generale delle autorità e dei media, nazionali e internazionali.
Prima e ultima notte in Ucraina
A quel punto ero un uomo libero in territorio ostile. Dovevo solo attendere la mattina successiva per salire sul primo volo per Odessa e proseguire il mio viaggio. Nessuna autorità avrebbe potuto fermarmi di nuovo. La lama di un coltello, sì, avrebbe potuto.
Quella notte insieme a me dormirono il console e il funzionario dell’ambasciata. Nel senso che dormirono nella mia stessa stanza d’albergo, vicino all’aeroporto. Nello stesso letto a due piazze. Dovevo essere protetto. Ero diventato un bersaglio.
La mattina successiva alle nove e mezza mi stavo imbarcando sul volo che sarebbe partito mezz’ora dopo per Roma. Non valeva la pena proseguire. Troppo pericoloso. Nella mia testa, solo la voglia di riabbracciare i miei cari.
Tratto dal libro Ucraina, dal Donbass a Maidan, di Franco Fracassi.
Per l’acquisto del libro scrivere all’indirizzo email: francofracassi1@gmail.com